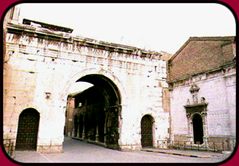|
|
|
|
Nell'antichità
romana, Fano era Fanum Fortunae.
Cesare scrisse che la occupò appena passato il Rubicone.
Il tempio della Fortuna, che diede il nome e l'origine alla
città, sorse molto prima. Nel 207 a.C. fu combattuta, a
qualche chilometro dall'abitato, la famosa battaglia fra
Romani e Cartaginesi, storicamente conosciuta come battaglia
del Metauro. La strada consolare Flaminia, che da Roma giunge
a Fano, favorì certamente lo sviluppo del primo nucleo di
abitazioni. Nel 540 Fano rovinò bruciata dai Goti di Vitige.
I generali di Giustiniano, Belisario e Narsete, la ricostruirono
(541-565). Fano fu centro della Pentapoli Marittima formata
dalle città di Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia ed Ancona
e Papa Giovanni VIII, per mettersi al sicuro fuori Roma,
dimorò in questo centro nell'873. Nel 999 Ottone II donò
Fano a Papa Silvestro II, mentre nella prima metà del secolo
XII Pesaro e Senigallia posero assedio a Fano che fallì
(1140) in seguito al patto di alleanza concluso tra Fano
e Venezia. Nel 1241 la città fu assediata da Federico II
che, non avendola potuta espugnare, si sfogò devastandone
il territorio. Poi (1529) ebbe la dominazione di Manfredi,
principe di Taranto. Al principio del XIII secolo Fano ebbe
per qualche anno il dominio della famiglia d'Este e dopo
violenti tentativi, i Malatesta imposero la loro dominazione
sul territorio fanese. Caduta la signoria dei Malatesta,
il territorio fanese passò al dominio diretto della Chiesa,
opponendosi sempre tenacemente alle mire del duca di Urbino
che voleva aggregarsi l'antica Fanum. Il I maggio del 1501
Papa Alessandro VI Borgia elesse il figlio Cesare vicario
perpetuo della città, il quale, a sua volta, elesse Fano
come sede del commissario generale per il ducato di Romagna.
Caduti i Borgia, Fano tornò sotto il dominio diretto di
Roma e poi sotto quello del principe di Macedonia, un papista
che nel 1516 e nel 1526 dovette rifugiarsi nella rocca e
difendersi dai sanguinosi assalti dei fanesi. Dopo altre
peripezie, le forze di Lorenzo de'Medici furono assediate
a Fano (1517) da quelle dei Della Rovere e, nel 1533, i
principali partigiani dei Medici, furono uccisi nel palazzo
Civico, dopo una violenta sollevazione popolare. Ma la lotta
contro i tentativi dei duchi d'Urbino fu quella che più
tormentò i fanesi. Il pontificato del concittadino Papa
Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini (1592-1605), non migliorò
le condizioni anche se molti fanesi, che altrove avevano
acquistato lustro e ricchezza, eressero palazzi signorili,
fecero costruire e decorare templi, favorirono gli studi
istituendo collegi ed accademie e quella che fu una famosa
università che fu poi soppressa nel 1894 da Leone XII. Durante
il periodo napoleonico Fano, nel Febbraio 1797, fu aggregata
alla Repubblica Romana, della quale fu città di confine
con la Repubblica Cisalpina. Questa delicata ubicazione
fu causa di un vero martirio della città specie nel 1799,
allorché cominciarono gli attacchi, gli sbarchi ed i saccheggi
degli austro-russi-turchi, cui seguirono contrattacchi,
saccheggi, fucilazioni dei francesi. Nel periodo del tramonto
napoleonico, Fano ritornò città-confine fra lo Stato Pontificio
e il Regno di Napoli perché Gioacchino Murat dichiarò suo
confine il Metauro. Altre reazioni, altre lotte, altri contributi
di sangue e di energia per la libertà, videro sempre i fanesi
fra i primi sia nel 1815, che nel periodo dal 1831 al 1870.
All'alba del 12 settembre 1860, battute le truppe pontificie,
Fano si unì al regno d'Italia. Fano fu sede di un collegio
dove sin dal 1680 si insegnava il diritto canonico e civile,
filosofia, teologia e medicina. A tale collegio il 25 Febbraio
1729, Papa Benedetto XIII concesse il diritto di conferire
lauree che avevano lo stesso valore di quelle delle università
di Bologna, Padova e di qualunque altro Studio generale
d'Italia, L'imperatore Carlo VI poi, con suo diploma del
23 Giugno 1731, dichiarava che le lauree concesse dalla
università di Fano erano valide in tutto il Sacro Romano
Impero e cioè in Germania, Italia Spagna e Francia. Papa
Leone XII nel 1824 tolse il diritto all'università di Fano
di concedere lauree. Tale diritto però fu tenacemente conservato
fino al 1841, per un periodo quindi di 161 anni. Anche oggi
Fano è un noto centro di studi.
|
|
|
|
|
Il
Palazzo della Ragione: eretto nel 1299 è in stile
romanico su grandi arcate cui sovrastano eleganti quadrifore
che ricordano quelle del palazzo dell'Arengo a Rimini. Una
torre fu innalzata nel 1739 sull'angolo occidentale dell'edificio.
L'interno, celebre per aver ospitato nel 1357 il grande
Parlamento della Marca che promulgò le famose Costituzioni
Egidiane e per aver racchiuso, dal 1677, l'importante Teatro
della Fortuna di Giacomo Torelli è, dal 1863, la sede del
nuovo Teatro della Fortuna di Luigi Poletti.
|
| La
Corte Malatestiana: è costituita da due distinte fabbriche:
quella di sinistra con quattro bifore su un porticato, risale
al XV secolo: quella di destra con elegante loggiato è del
1544. Nel porticato, come nell'interno, sono custodite le
raccolte del Museo Civico, ricco di ceramiche, sculture, cippi,
sarcofaghi (per lo più risalenti ad epoche romane), maioliche,
armi, monete, stoffe. Particolarmente notevole, nel porticato,
il pavimento a mosaico venuto alla luce nell'ultimo dopoguerra.
Nelle medesime stanze sono esposti quadri e affreschi costituenti
la Pinacoteca Civica. Le opere più notevoli sono: una tavola
di Giovanni Santi padre di Raffaello) raffigurante "La Madonna
e Santi"; un politico di Michele Giambono; la famosa tela
del Guercino raffigurante "L'Angelo Custode", la pala dell'altare
con la "Resurrezione di Lazzaro" dei Morganti; la "Annunciazione"
di Guido Reni e altre grandi tele del Ceccarini, di Simone
Cantarini e di Mattia Preti. |
 |
| Un
altro notevole complesso monumentale formano, in via San Francesco,
il Portico e il Convento del Santo di Assisi. Il portico,
a tre arcate ogivali, ingresso alla trecentesca ex chiesa
francescana custodisce gli interessanti monumenti funerari
dei Malatesta; il Convento, dalle sobrie linee vanvitelliane,
è oggi trasformato in Palazzo Municipale. |
| Per
la città innalzano un suggestivo inno all'arte le tante Chiese
che artisti di grido ingemmarono dei loro preziosi dipinti.
Fra queste vanno segnalate: La Chiesa di San Pietro in
Valle (1617): costruita con affreschi di allievi del Barocci
e quadri del Ceccarini, del Cantarini ecc. Notevole il soffitto
affrescato da Antonio Viviani detto il Sordo di Urbino. La
chiesa di San Paterniano (1550): costruita su progetto
del Sansovino, con elegantissimo chiostro rinascimentale e
dipinti del Tiarini, Ridolfi e Bonone. Vi si ammira anche
un crocifisso del napoletano Giacomo Colombo eseguito nel
1706. La chiesa di Santa Maria Nova (detta anche di
San Salvatore): in una unica navata settecentesca in cui si
trovano esposte: una tavola raffigurante "La Visitazione"
di Giovanni Santi e due pale di altare con "L'Annunciazione"
e la "Madonna e Santi" di Pietro perugino con predella attribuita
al giovane Raffaello Sanzio. Notevole anche il coro quattrocentesco
dei maestri senesi Antonio e Andrea Barilli La Basilica
Cattedrale (secolo VIII): rinnovata in stile romanico
nel XII secolo con bella facciata rielaborata e restaurata.
Nell'interno, molto rimaneggiato, ma chiaramente romanico
nella struttura generale, sono notevoli gli affreschi del
Domenichino nella barocca cappella Nolfi, due tele di Ludovico
Caracci e di Andrea Lilli e un pulpito frammentario con bellissimi
altorilievi romanici. La ex chiesa di Santa Maria del Suffragio:
con affresco del Trecento raffigurante il crocifisso, di scuola
riminese. La chiesa di San Tommaso Apostolo, oggi dell'Adorazione:
con un dipinto in tavola (1546) del pittore fanese Giuliano
Persiutti raffigurante il Santo. La chiesa di Sant'Antonio
Abate: con la "Sacra Famiglia" del Ceccarini e un "S. Antonio
Abate" di Carlo Magini. La ex chiesa di San Michele:
con facciata rinascimentale allietata dal ricco portale di
Bernardino da Corona e dalla ricomposizione in bassorilievo
dell'Arco di Augusto. Arco d'Augusto: questo arco onorario
(porta principale della città romana) fu innalzato prima del
9 dopo Cristo, insieme con le mura di Fano, varco monumentale
alla via Flaminia che qui raggiunge il mare. È a tre fornici
con paramento esterno a grandi blocchi squadrati di pietra
appenninica. Al di sopra della trabeazione sorgeva un porticato
di cui restano pochi frammenti a causa del cannoneggiamento
(1463) ordinato dal duca di Urbino. Unita alla parte interna
dell'Arco è la Loggia di San Michele, restaurata nel 1925.
|
| Eremo
di Monte Giove: fondato dal monaco camaldolese Galeazzo
Gabrielli di Fano nel 1650. Nella chiesa di stile barocco
risalta il Coro. Il convento fu incamerato ai beni dello Stato
in seguito alla soppressione napoleonica e di conseguenza
abbandonato dai monaci. Nel 1925 fu riacquistato dai camaldolesi
che tuttora lo occupano. |
| La
Chiesa di San Pietro in Episcopio (vulgo S. Piruscuin):
antichissima prima cattedrale paleocristiana in cui è leggenda
sia stato sepolto il capitano Bartolagi da Fano caduto combattendo
contro Attila nella difesa di Aquileia. Recentemente restaurata,
è stata riaperta al culto. |
|